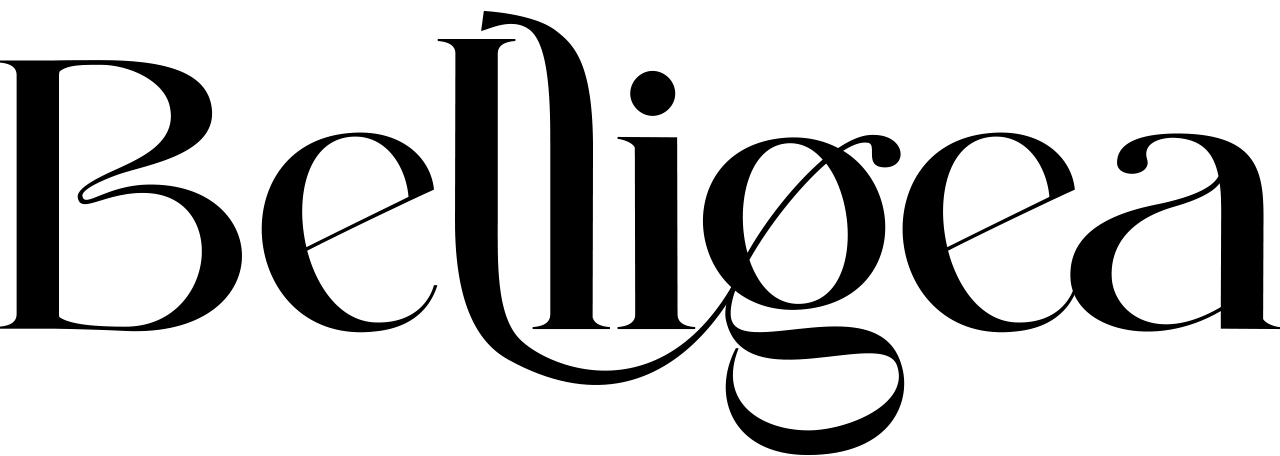Sorpresa OVS: assunzioni in tutta Italia | Basta un click per il colloquio
Vetrina negozio OVS (Depositphotos) Belligea.it Scopri come candidarti per fare un colloquio presso uno dei negozi di abbigliamenti più famosi d'Italia: OVS apre le sue...
Lifestyle
Buitoni, addio per sempre: anche la storica residenza resterà un ricordo
Buitoni (depositphotos) - belligea.it Una residenza storica che possiamo dire faccia parte del patrimonio paesaggistico italiano: eppure sembra diventerà altro. Buitoni è una delle eccellenze...
Lavatrice silenziosa, non mi fregano più: solo una è davvero a zero rumore e la faccio di notte
Una lavatrice, zero rumore (depositphotos) - belligea.it Molti produttori di lavatrici millantano zero rumore durante il lavaggio o la centrifuga: solo lei è la perfetta...
Prosciutto Crudo, altro che Parma: non ne farò mai più a meno dopo aver assaggiato questo
Prosciutto crudo (depositphotos) - belligea.it Una delle eccellenze italiane declinata nel migliore dei modi: si tratta di un prodotto eccezionale, ecco qual è e dove...
Ciao ciao vicini molesti: non potranno disturbarti né curiosare mai più | Con pochi spicci addio agli impiccioni
Due uomini che guardano al di là della staccionata del loro giardino (Depositphotos) Belligea.it Tieni alla larga gli impiccioni con questi rimedi semplici ed economici:...
La mia dietologa me l’ha confessato: “Non dovrei dirlo ma…” | Ho bloccato subito la fame nervosa
Giovane donna con cerotto sulla bocca e dolci sul tavolo (Depositphotos) Belligea.it Scopri come bloccare la fame nervosa, grazie ai consigli della dietologa: da oggi,...
La mia dietologa mi ha messo un formaggio nella dieta: sono salva | Non ne posso fare a meno
Il formaggio nella dieta - Fonte: Depositphotos - Belligea.it Ecco qual è il formaggio che la dietologa concede durante la dieta che fa rallegrare tutti...